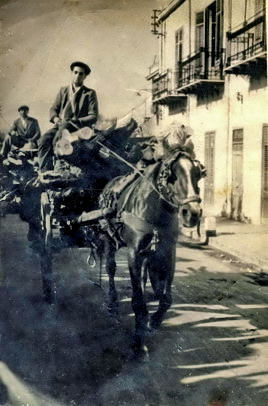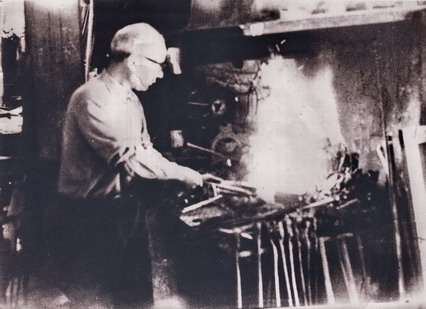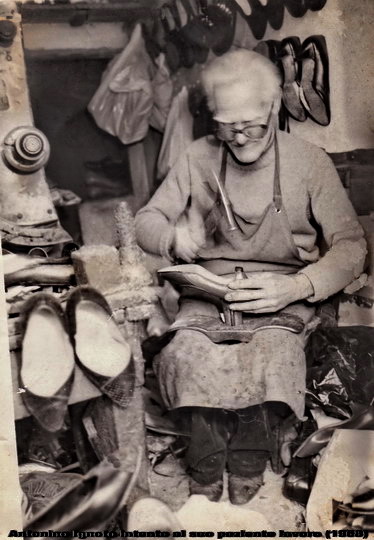Arti, mestieri
e professioni del passato
Arti e mestieri tipici del passato
Intorno al 1900 diverse attività artigiane divennero tipiche di
Capaci. Ci riferiamo all’arte del ricamo ma anche ai mestieri di saponaro,
carrettiere, maniscalco e carradore, cordaio, stagnino, bottaio, calzolaio ormai in parte
o del tutto travolti dal convulso ed inesorabile scorrere del tempo e
dall’affannosa ricerca di tecnologie sempre più avanzate. Attività che, per
adeguarsi alle necessità del momento o per seguire il mutare delle condizioni economiche e
sociali, spesso
vennero
esercitate in maniera alternativa da molte maestranze, per cui
divennero
ben presto sinonimi della capacità e della laboriosità di questa
cittadina essendo entrate prepotentemente a far parte inscindibile della nostra
storia.
Ricamatrici
Il lavoro del ricamo, eseguito per l’allestimento della
dote delle ragazze di famiglia od anche per commissioni delle signore più
facoltose del paese, a secondo dell’estensione del capo da ricamare, si svolgeva
o con un “tilaru” (telaio) lungo, in cui bisognava lavorare a quattro mani, o con
uno più maneggevole formato da due cerchi concentrici del diametro di 30
cm. circa, in cui veniva incastrato il tessuto. I punti maggiormente eseguiti
erano i così detti punti sfilati: il 400, il 500, il 700; il punto ad
intaglio, il punto rodi, il punto croce, il pittoresco, il punto norvegese. Ed
accanto a questi punti impegnativi fiorirono pure quelli ai ferri, con i quali
si facevano calze e maglioni, e quelli ad uncinetto, un piccolo arnese della
lunghezza di 25 cm. circa e di diametro variabile fino a 3 mm., con il quale il
disegno si sublimava in arte con la produzione di bellissimi copriletto
matrimoniali, tende, centri da tavolo, tappeti e quanto di più fantastico e
suggestivo suggeriva l'inventiva.
Ormai le figure delle
ricamatrici sono quasi del tutto scomparse ma i loro lavori continuano a
rappresentare ancora oggi un inestimabile patrimonio artistico e culturale a
testimonianza dell’ingegno e dell’operosità femminili per i quali la loro notorietà ha varcato i confini
territoriali contribuendo a scrivere una delle pagine più belle nella storia
dell'artigianato locale.
Saponaro
Accattivante anche se faticosa e poco remunerabile era la
lavorazione per la produzione del sapone ottenuto utilizzando la “muria”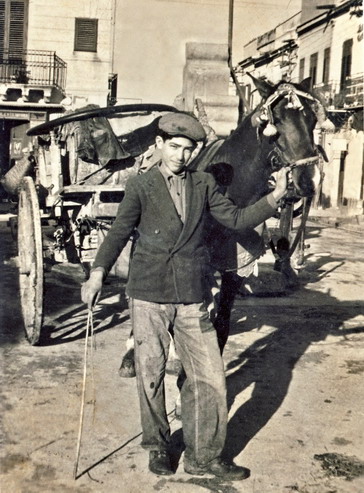
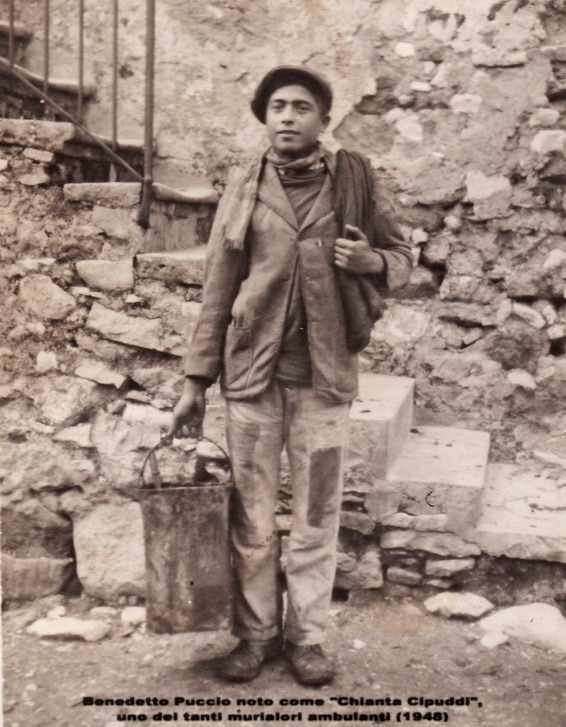 (morchia, residuo dell’olio d’oliva) che il saponaro comprava nel frantoio
locale ed in quelli dei paesi limitrofi o reperiva attraverso i “murialori”
(commercianti che l’acquistavano in giro per i paesi). La muria veniva raccolta
e conservata negli “utra” (otri, recipiente in pelle di capra) e poi lavorata
con l’aggiunta di cenere (ottima quella di scorza di mandorle) il cui alto
contenuto di potassio dava origine al processo dell’idrolisi alcalina degli
acidi grassi. Il tutto veniva versato in una “quarara” (recipiente tipico) e
fatto bollire nell’apposita “fornacella” (struttura o fornello in conci di tufo od in pietra lavica). Dopo cinque ore di cottura il sapone
che via via si formava, attraverso dei tubi collegati, si riversava nelle vasche
di raffreddamento da dove veniva rimosso e conservato in recipienti di latta od
in barili, pronto per essere collocato in commercio. Il sapone prodotto a Capaci
veniva usato per lavare la biancheria ed era prevalentemente di tipo molle e
perciò veniva chiamato “trema-trema”. Il colore verde era ottenuto con l’aggiunzione di “pale” (foglie di ficodindia) nella prima fase di cottura.
(morchia, residuo dell’olio d’oliva) che il saponaro comprava nel frantoio
locale ed in quelli dei paesi limitrofi o reperiva attraverso i “murialori”
(commercianti che l’acquistavano in giro per i paesi). La muria veniva raccolta
e conservata negli “utra” (otri, recipiente in pelle di capra) e poi lavorata
con l’aggiunta di cenere (ottima quella di scorza di mandorle) il cui alto
contenuto di potassio dava origine al processo dell’idrolisi alcalina degli
acidi grassi. Il tutto veniva versato in una “quarara” (recipiente tipico) e
fatto bollire nell’apposita “fornacella” (struttura o fornello in conci di tufo od in pietra lavica). Dopo cinque ore di cottura il sapone
che via via si formava, attraverso dei tubi collegati, si riversava nelle vasche
di raffreddamento da dove veniva rimosso e conservato in recipienti di latta od
in barili, pronto per essere collocato in commercio. Il sapone prodotto a Capaci
veniva usato per lavare la biancheria ed era prevalentemente di tipo molle e
perciò veniva chiamato “trema-trema”. Il colore verde era ottenuto con l’aggiunzione di “pale” (foglie di ficodindia) nella prima fase di cottura.
La figura del saponaro oggi è del tutto scomparsa, ma, come
per tutte le arti ed i mestieri desueti, essa resta a testimoniare il valore e
l’impegno prodigati per lo sviluppo economico e sociale della città, a memoria
delle future generazioni.
Una delle più rappresentative fu senza dubbio quella di “U zu Rusariu Pappatuni” (Rosario Troia) la cui attività, avviata alla fine
dell’800 dal padre Giuseppe ed ereditata negli anni '30, venne molto apprezzata
e diffusa in tutto il palermitano fin verso la fine del 1958.
Andrea Troia, detto “Attareddu” e Antonino Troia, noto come
“Peri Chiummu”, sono due altri tipici rappresentanti di questo mestiere duro ma
affascinante di cui, per circa un ventennio dagli anni 1930 in poi, hanno
contribuito a mantenere alto il prestigio suscitando un notevole interesse anche
oltre i confini territoriali.
Carrettiere
Il
carrettiere era un trasportatore di merci varie che andavano dai prodotti
stagionali della campagna al materiale da costruzione, al
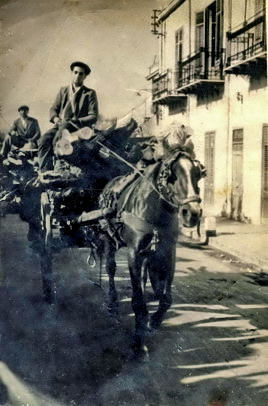 carbone, al concime.
Generalmente lavorava per conto di terzi (proprietari terrieri, commercianti e
costruttori); raramente in proprio. Godeva, però, della proprietà dei mezzi di
trasporto: carretto e cavallo. La forma di pagamento era quella a viaggio e la
retribuzione veniva pattuita in base al percorso da compiere ed al tipo di
trasporto. Il suo lavoro si svolgeva “stratuna stratuna” (sulle strade) ed i
luoghi di sosta erano i “funnachi”, strutture coperte ove albergare assieme agli
animali e ristorarsi con un “piattu 'i pasta agghiu e ogghiu” (pasta con aglio
ed olio, oggi molto apprezzata dalle buone forchette come “pasta alla
carrettiera”) o mangiare all’asciutto "pani cu cumpanaggiu” (pane con formaggio
e olive).
carbone, al concime.
Generalmente lavorava per conto di terzi (proprietari terrieri, commercianti e
costruttori); raramente in proprio. Godeva, però, della proprietà dei mezzi di
trasporto: carretto e cavallo. La forma di pagamento era quella a viaggio e la
retribuzione veniva pattuita in base al percorso da compiere ed al tipo di
trasporto. Il suo lavoro si svolgeva “stratuna stratuna” (sulle strade) ed i
luoghi di sosta erano i “funnachi”, strutture coperte ove albergare assieme agli
animali e ristorarsi con un “piattu 'i pasta agghiu e ogghiu” (pasta con aglio
ed olio, oggi molto apprezzata dalle buone forchette come “pasta alla
carrettiera”) o mangiare all’asciutto "pani cu cumpanaggiu” (pane con formaggio
e olive).
La
sosta nei fundaci costituiva Il momento più bello della giornata poichè, oltre a
concedere un meritato riposo dalla fatica del duro lavoro, favoriva lo scambio di
esperienze e di informazioni utili ma rappresentava soprattutto l’occasione
propizia per dare libero sfogo alla gioia del canto che spesso sfociava in gare
spontanee e appassionate.
I
temi evocati erano quelli reali, ricchi di contenuti umani e sociali, spesso pervasi da
un fascino e da una sensibilità creativa particolari, che inneggiavano alle
gioie dell’amore e della vita od esprimevano una intensa, struggente malinconia
per il tempo che fugge.
Ragione di incontro erano poi le fiere di bestiame e le feste paesane, religiose
e non, dove essi convenivano insieme alle famiglie con cavallo e carretto
riccamente bardati e dove certo si coglieva sempre il momento opportuno per
intonare anche a più voci le loro caratteristiche stornellate.
E
non era raro ascoltare i loro canti accompagnati dalle note arcaiche e vibranti
del “marranzanu” (scacciapensieri) o dal suono voluttuoso e avvolgente del
“fiscaleddu” (flauto) e dal frenetico tintinnio dei “tambureddi” (tamburelli)
mentre il vibrare basso e profondo del “bummulu” (anfora di terracotta
variamente dipinta che emette un suono quando vi si soffia dentro) scandiva ritmicamente i tempi.
Occorre aggiungere che l’appartenenza alla categoria era avvertita con
molto orgoglio poichè i carrettieri si consideravano profondi
conoscitori della vita per le esperienze acquisite nel corso dei loro viaggi,
come sentita era pure la distinzione tra “cacciari a misteri” (guidare il
cavallo ad arte) e chi “caccia a fumeri” (guidare come un portatore di letame).
Tra le figure
più note (e sono veramente tante) ricordiamo: "U zu Cicciu Trotta" (Francesco Trotta),
"Pippinu u piccialaru" (Giuseppe Vassallo), "Ciccu puccidduzzu" (Francesco
Rizzo), "U zu paliddu mastrupaulu" (Paolo Rizzo) ed i fratelli
Giuseppe, Giovanni e Antonio Puccio, intesi "Chianta Cipuddi", mentre l'unico fundaco
esistente nel territorio ed ubicato
in
questo Corso Vittorio Emanuele - angolo Piazza Venezia - con un
abbeveratoio
antistante era gestito da Antonio Croce detto "'Ucca ranni".
Di
questo mondo così riccamente articolato non rimane quasi più nulla poiché il
passaggio ad un nuovo mezzo di trasporto, quello motorizzato, è stato naturale e senza
soluzioni di continuità.
Esso comunque è ormai parte della nostra storia recente e, seppure comincia a
presentarsi in maniera frammentaria alla memoria di qualche anziano, ancora oggi
conserva intatti i suoi valori affettivi nelle espressioni più
caratteristiche della nostra musica etnica.
Maniscalco e Carradore
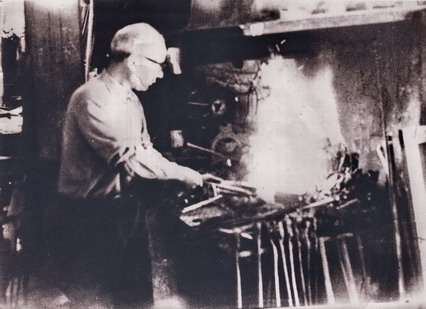 Fortemente correlati a quello
di carrettiere erano due altri mestieri che, per molti aspetti, trovavano piena rappresentatività in
“Mastru Roccu u firraru” (Rocco Enea) e “U zu Paliddu carritteri” (Paolo Sciara).
Fortemente correlati a quello
di carrettiere erano due altri mestieri che, per molti aspetti, trovavano piena rappresentatività in
“Mastru Roccu u firraru” (Rocco Enea) e “U zu Paliddu carritteri” (Paolo Sciara).
Il primo attendeva all’attività di Fabbro nella sua
attrezzatissima officina dalla lunga parete interamente adorna di tenaglie,
lame, pinze e punteruoli vari, ove, oltre a realizzare cancelli, inferriate e
balconate dalle forme molto belle e variegate od a costruire attrezzi per i
contadini, esercitava anche il lavoro di Maniscalco dedito a preparare, davanti
alla scoppiettante fucina, i
ferri da applicare agli zoccoli dei cavalli ed i cerchi delle ruote dei carri,
forgiandoli sull’incudine ancora roventi con abili colpi del suo pesante
martello, a volte alternativamente e ritmicamente scanditi con l'aiuto di un
aiutante.
Il secondo svolgeva il mestiere di Carradore, ovvero, con l’ausilio di
pialle, asce, seghe e scalpelli modellava il legname e con sapiente maestria
riparava i raggi delle grandi ruote del carro o pazientemente ricostruiva e
rendeva funzionali telai, stanghe laterali e freni rudimentali che ne
costituivano i punti deboli.
Mestieri ormai scomparsi con l’avvento di nuove tecnologie ma che hanno
accompagnato a lungo un difficile periodo della nostra economia fino agli anni
’70 caratterizzando tuttavia in modo straordinario la grande vitalità del nostro
artigianato locale.
Cordaio
Anche “u curdaru” (il cordaio) come luogo di lavoro aveva la strada. Per lui, infatti, qualsiasi spazio andava
bene purchè abbastanza esteso e poco frequentato da consentire la stesura dei
filati.: le lunghe vie strette ed ombrose o le solitarie piazzole retrostanti le
chiese. Le operazioni di filatura erano il frutto di una grande maestrìa,
acquisita in anni di esperienza, unita ad una speciale abilità nel coordinare i
movimenti delle mani e dei piedi. L’attività nel suo complesso richiedeva la
collaborazione esperta di più persone che in fasi contemporanee più che
successive eseguivano le operazioni necessarie: la manovra a mano della ruota
per imprimere movimento alle pulegge; il bagno in vasche di pietra in cui
venivano immerse le matasse delle filacce; la lavorazione e la torsura delle
corde stese ad una certa altezza da terra; la stesura per asciugarle.
Ormai da tempo il mestiere del cordaio è caduto in disuso ma il ricordo di
quanti lo hanno esercitato è tuttavia parte integrante della storia di questa
comunità. E certamente Erasmo Vassallo, meglio noto come “’Raziu l’Ummira”, dal
1932 e per quasi un ventennio, ne è stato uno dei suoi più tipici rappresentanti.
Stagnino
Un mestiere che tuttora resiste al tempo è quello dello “stagnataru” o "stagnaru" (stagnino),
un artigiano che per l’esecuzione della sua professione poteva contare su due
luoghi: il laboratorio e le strade. Il lavoro consisteva nella riparazione,
mediante saldature a
stagno, di vari tipi di recipienti metallici: pentole, “quarare”
(pentoloni), “quartare” (contenitori d’acqua in lamiera) ma soprattutto
suppellettili di rame sulle cui parti interne stendeva un fitto strato di
zinco che agiva da isolante contro le sostanze tossiche rilasciate dal rame a
contatto con gli alimenti. Gli arnesi usati dallo stagnino erano: delle grosse
forbici per tagliare le lamiere da utilizzare per i rattoppi; un ferro con
manico termoisolante da immergere nella brace incandescente di un fornello per
fondere lo stagno ed applicarlo nei posti dove era necessario; delle barrette di
una lega di stagno e piombo (per le saldature dolci) e di una lega di zinco,
rame e piombo (per le saldature più forti); dei martelli di varie dimensioni per
sagomare i rattoppi di lamiera.
Il più noto ed il più abile fu senza dubbio "Mastru Vicenzu u stagnataru"
(Vincenzo Fontana) il cui laboratorio, fin verso la fine degli anni '60, era situato
in questa centralissima piazza Calogero Troia.
Bottaio
Il bottaio o “vuttaru” era uno di quei mestieri che venivano considerati
privilegiati e di difficile esecuzione. Il lavoro veniva eseguito a mano e
consisteva nel sistemare delle listelle di legno, di preferenza di castagno o
rovere (per le botti che dovevano contenere vini o liquori pregiati).
Normalmente esse erano più larghe nella parte centrale e più strette alle
estremità e variavano in numero e dimensioni in funzione della capienza della
botte da costruire. Le listelle o toghe, perfettamente piallate, venivano
sistemate una ad una in una forma circolare al cui interno la fiamma di un
fornello sviluppava il vapore indispensabile per rendere il legno più duttile ed
elastico alla lavorazione e facilitare la necessaria curvatura delle doghe, ma
era essenziale anche per liberarle dalle sostanze tossiche del legno (il
tannino), facilmente trasferibili nel vino. Per completare il lavoro occorrevano
inoltre sei cerchi di ferro di diverse dimensioni e due coperchi o “timpagni” di
diametro perfettamente adeguato ai fori finali della botte. Era a questo punto
che l’arte del bottaio si rivelava in tutta la sua magia: nel far aderire le
toghe l’una all’altra e nel tenerle unite con i cerchi metallici fissati
all’esterno con uno speciale attrezzo a forma di scalpello smussato, senza
l’aiuto di collanti. Il prodotto finito era a perfetta tenuta stagna.
Purtroppo la moderna tecnologia ed il ricorso massiccio a contenitori
d’acciaio e di vetroresina hanno fatto scomparire il fascino di un mestiere
così pregevole e privilegiato. Ma come tale la figura del suo esecutore è parte
integrante della nostra esperienza storica pronta a ricordare alle future
generazioni l’alto valore tecnico ed il grande prestigio delle nostre più belle
tradizioni artigiane.
In quest'arte eccelsero i fratelli Cappello, Antonio e Antonino (inteso "Nenè"), che
degnamente hanno saputo dar
lustro all'attività ereditata dal padre Calogero.
Calzolaio
 Il mestiere più modesto era forse quello “du scarparu”
(del calzolaio) ma sorprendono ancora oggi la solerzia, la pazienza, la passione con
le quali l’umile artigiano attendeva al suo diuturno lavoro. Questo consisteva
nel costruire scarpe su misura, aggiustare, risuolare, mettere i sopratacchi e
ricucire le parti che andavano deteriorandosi o magari rinforzare le suole con
l'aggiunta di "tacce" (chiodi a testa particolarmente ampia e arrotondata) e "puntette" (sorta di ferri a forma ricurva
collocati sulle punte e sui tacchi) per
resistere meglio all'usura. La materia prima era costituita
dalle pelli che potevano essere più o meno pregiate e le scarpe più o meno
rifinite, accurate, solide e robuste secondo l’uso cui erano destinate. Gli
attrezzi, ovvero gli strumenti indispensabili del suo lavoro, erano: i "fuimmi"
in ferro (forme,
modelli riproducenti la forma del piede), di
varie dimensioni, nei quali venivano inserite le scarpe
da trattare; “u trincettu” (coltello caratteristico e affilatissimo); il
martello (anch’esso dalla forma particolare); tenaglia, lesina, spago, aghi,
cera, pece, vetro per levigare le suole e tutta una serie di piccoli chiodi “a siminziedda” detti "zzippulicchi". Il tutto
predisposto su un basso tavolo da lavoro,
ovvero “u bancareddu”. La
manifattura delle scarpe da lavoro, in particolare, si ispirava al principio
della robustezza e della solidità per cui l’attività del calzolaio si è
dimostrata sempre molto preziosa per le esigue finanze delle famiglie contadine.
Il mestiere più modesto era forse quello “du scarparu”
(del calzolaio) ma sorprendono ancora oggi la solerzia, la pazienza, la passione con
le quali l’umile artigiano attendeva al suo diuturno lavoro. Questo consisteva
nel costruire scarpe su misura, aggiustare, risuolare, mettere i sopratacchi e
ricucire le parti che andavano deteriorandosi o magari rinforzare le suole con
l'aggiunta di "tacce" (chiodi a testa particolarmente ampia e arrotondata) e "puntette" (sorta di ferri a forma ricurva
collocati sulle punte e sui tacchi) per
resistere meglio all'usura. La materia prima era costituita
dalle pelli che potevano essere più o meno pregiate e le scarpe più o meno
rifinite, accurate, solide e robuste secondo l’uso cui erano destinate. Gli
attrezzi, ovvero gli strumenti indispensabili del suo lavoro, erano: i "fuimmi"
in ferro (forme,
modelli riproducenti la forma del piede), di
varie dimensioni, nei quali venivano inserite le scarpe
da trattare; “u trincettu” (coltello caratteristico e affilatissimo); il
martello (anch’esso dalla forma particolare); tenaglia, lesina, spago, aghi,
cera, pece, vetro per levigare le suole e tutta una serie di piccoli chiodi “a siminziedda” detti "zzippulicchi". Il tutto
predisposto su un basso tavolo da lavoro,
ovvero “u bancareddu”. La
manifattura delle scarpe da lavoro, in particolare, si ispirava al principio
della robustezza e della solidità per cui l’attività del calzolaio si è
dimostrata sempre molto preziosa per le esigue finanze delle famiglie contadine.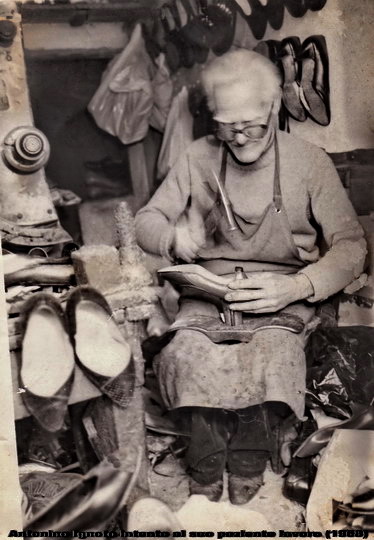

Uno
dei più tipici esempi locali di questo mestiere è rappresentato senza dubbio da
“Mastru Vartulu u scarparu” (Bartolomeo
Giambona), una figura che rimane legata
alla memoria di quanti lo hanno apprezzato per la sua capacità creativa e l’attacamento
al lavoro davanti al suo “bancareddu” ordinatamente ripartito e, nelle
luminose giornate estive, collocato all’aperto, a fianco della porta di casa, sul
marciapiede di una delle più lunghe e antiche vie del centro storico, “A Vanedda
Longa” o Via Francesco Crispi. Ma sono tanti e tanti altri gli esperti di questa
attività
che, per l'umiltà del loro lavoro e la straordinaria maestria d'esecuzione,
affollano i nostri ricordi e perciò con grande rispetto citiamo almeno Francesco
Paolo Abate, noto come "Mastru Paulu u scarparu", e Antonio Puccio, inteso "Mastru
Nenè u scarparicchiu", nonchè "Mastru Ninuzzu" (Antonino Lo Bello) e
Antonino Ignoto, inteso "u mutu", tenendo presente che, accanto a questi artigiani
locali, altri ancora provenienti dai paesi vicini, per necessità o per passione,
esercitavano l'umile mestiere in forma ambulante.
Il segno dei tempi
Poveri mestieri che, per diversi decenni ed, in generale, fino all'immediato
dopoguerra, configurarono una condizione economica molto drammatica che tuttavia
venne affrontata con lo spirito di laboriosità e di intraprendenza di sempre;
doti di caparbietà che valsero al capacioto la nomea di "testa dura"
e che segnarono per sempre il suo destino di cittadino del mondo pronto ad
adeguarsi alle veloci trasformazioni dei tempi.
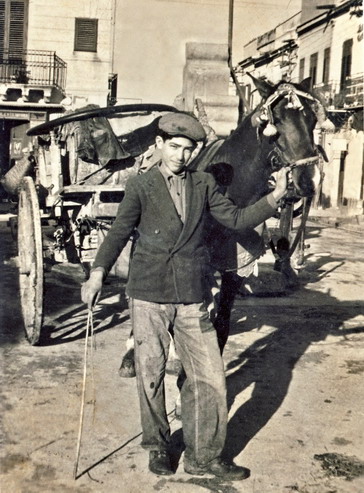
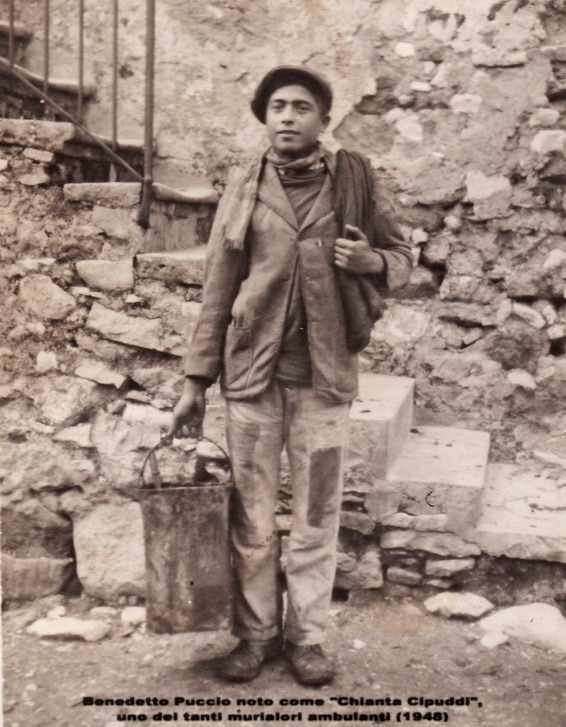 (morchia, residuo dell’olio d’oliva) che il saponaro comprava nel frantoio
locale ed in quelli dei paesi limitrofi o reperiva attraverso i “murialori”
(commercianti che l’acquistavano in giro per i paesi). La muria veniva raccolta
e conservata negli “utra” (otri, recipiente in pelle di capra) e poi lavorata
con l’aggiunta di cenere (ottima quella di scorza di mandorle) il cui alto
contenuto di potassio dava origine al processo dell’idrolisi alcalina degli
acidi grassi. Il tutto veniva versato in una “quarara” (recipiente tipico) e
fatto bollire nell’apposita “fornacella” (struttura o fornello in conci di tufo od in pietra lavica). Dopo cinque ore di cottura il sapone
che via via si formava, attraverso dei tubi collegati, si riversava nelle vasche
di raffreddamento da dove veniva rimosso e conservato in recipienti di latta od
in barili, pronto per essere collocato in commercio. Il sapone prodotto a Capaci
veniva usato per lavare la biancheria ed era prevalentemente di tipo molle e
perciò veniva chiamato “trema-trema”. Il colore verde era ottenuto con l’aggiunzione di “pale” (foglie di ficodindia) nella prima fase di cottura.
(morchia, residuo dell’olio d’oliva) che il saponaro comprava nel frantoio
locale ed in quelli dei paesi limitrofi o reperiva attraverso i “murialori”
(commercianti che l’acquistavano in giro per i paesi). La muria veniva raccolta
e conservata negli “utra” (otri, recipiente in pelle di capra) e poi lavorata
con l’aggiunta di cenere (ottima quella di scorza di mandorle) il cui alto
contenuto di potassio dava origine al processo dell’idrolisi alcalina degli
acidi grassi. Il tutto veniva versato in una “quarara” (recipiente tipico) e
fatto bollire nell’apposita “fornacella” (struttura o fornello in conci di tufo od in pietra lavica). Dopo cinque ore di cottura il sapone
che via via si formava, attraverso dei tubi collegati, si riversava nelle vasche
di raffreddamento da dove veniva rimosso e conservato in recipienti di latta od
in barili, pronto per essere collocato in commercio. Il sapone prodotto a Capaci
veniva usato per lavare la biancheria ed era prevalentemente di tipo molle e
perciò veniva chiamato “trema-trema”. Il colore verde era ottenuto con l’aggiunzione di “pale” (foglie di ficodindia) nella prima fase di cottura.